Il 24 Aprile del 1986 usciva nelle sale italiane Vivere e morire a Los Angeles, thriller poliziesco che, insieme con Manhunter, costituisce una doppietta incredibile per innovazione, sperimentazione e spericolata virata artistica del linguaggio cinematografico all’interno di un genere altamente codificato come il crime-movie. Anche il film di Friedkin, come quello di Mann (successivo di un anno), rimarrà un caso quasi isolato perché non riuscì a fare propriamente scuola, tanto fu personale e dirompente il modo in cui veniva raccontata una storia poliziesca. Non solo per il come è stato narrato ma anche per il cosa: la stessa trama del film prenderà infatti svolte assolutamente inedite e spiazzanti per un thriller poliziesco. Anche l’indelebile figura del protagonista spezzerà molti tabù relativi al genere. Da ricordare la costante che lega i due thriller e cioè l’attore principale William L. Petersen, futura star di CSI, lanciato proprio da questa pellicola e l’anno seguente da quella di Mann.
La sceneggiatura era basata sull’omonimo romanzo di Gerald Petievich, ex-agente dei servizi segreti che aveva riversato nel libro le sue esperienze, sia come agente assegnato alla sicurezza del presidente, sia come detective sulle tracce di falsari professionisti. Lo stesso Friedkin scrisse l’adattamento, in collaborazione con Petievich.
La trama
Il giovane e impulsivo agente federale Richard Chance perde l’amico e collega Jimmy Hart, ucciso dal falsario nonché pittore Rick Masters, sulle cui tracce era ormai da tempo. Il rapporto che legava Hart a Chance era praticamente filiale e infatti il nostro ne sarà stravolto. Non potrà dunque evitare di giurare a sé stesso di farla pagare a Masters, intraprendendo così una furiosa e ossessiva indagine che lo porterà oltre i limiti della legge pur di acciuffare la propria nemesi. In questa sarabanda investigativa dai toni sempre più parossistici coinvolgerà il più compassato collega John Vucovich (John Pankow) che, se all’inizio sarà entusiasta di lavorare al fianco di un collega così carismatico, in seguito, trovandosi invischiato in pericolosi atti illegali, entrerà decisamente in crisi.
Un attacco da storia del cinema
https://www.youtube.com/watch?v=LkV8Utz249s
Raccontiamo adesso in dettaglio l’incipit del film, che comprende un prologo e dei titoli di testa, non per mera acribia filologica, ma perché crediamo che mai come in questo caso i primi cinque minuti, solitamente basilari per stabilire i toni e le atmosfere di un film, ne determinino in questo caso anche la struttura narrativa.
Premettiamo che, come nei film di James Bond, anche in questo caso gli eventi raccontati nel prologo non hanno nulla a che fare con la vicenda della trama principale ma servono a presentare i personaggi principali e, come accennato, a stabilire un’atmosfera. Discorso diverso vale invece per i travolgenti titoli di testa.
Albeggia sulla sagoma dei grattacieli del centro di Los Angeles. Il corteo dell’auto presidenziale di Ronald Reagan attraversa la città. Le note pop-rock della title-track dei Wang Chung, To Live and and Die in LA, accompagnano le auto. Poi una panoramica notturna sulla città, a volo di elicottero, proprio come in qualche film di Michael Mann di qualche anno dopo. Siamo in un albergo dove facciamo la conoscenza dell’agente dei servizi segreti Richard Chance e del suo grande intuito. Sulla base di questo infatti egli intercetterà sul tetto dell’edificio un terrorista islamico imbottito di dinamite, pronto a farsi esplodere. Solo l’intervento del più maturo collega Jimmy Hart impedirà al terrorista di fare una strage, lasciando che l’uomo si faccia esplodere mentre è in volo dal terrazzo del grattacielo. Ora ci sono i titoli di testa.
Una pistola viene caricata al buio poi parte lo sparo, immortalato da quello che potrebbe essere il flash di una macchina fotografica. Sull’inquadratura di una nuova alba, (o forse è la stessa?), stavolta sulle tipiche palme losangeline, attacca il brano dei Wang Chung City of Angels che inizia con una lunga nota aspirata su cui si inseriscono delle note di pianoforte slegate tra loro, come in un’improvvisazione jazz. Saltuariamente rimbombano improvvisi dei bassi. Cominciano i titoli con un font verde e rosso molto accattivante. Sullo schermo appare il primo piano di un quadro inquietante, con un volto che ricorda quello di un Van Gogh dallo sguardo feroce. Poi stralci di Los Angeles: un treno merci sui binari, rimesse di auto, un carretto, la città degli angeli che si sta svegliando, non esattamente quella dei viali di Beverly Hills. All’interno delle lettere del titolo del film in sovrimpressione, vediamo un volto di donna truccato come un triste pagliaccio. Ancora scorci della città e poi una donna seduta sul pavimento di una stanza, forse la stessa. La nota aspirata prosegue, con gli interventi del piano. Poi il brano musicale si scatena all’improvviso in un ritmo sincopato di batteria elettronica, basso e riff di chitarra travolgendo lo spettatore che ormai è già rapito dal connubio ipnotico di musica e immagini. Ecco che i titoli di testa si trasformano in una grandiosa sinfonia pop-art in cui ogni inquadratura, apparentemente libera dalle altre, proprio come in una jam session, andrà a comporre un quadro preciso. Vediamo ancora il dettaglio di un dipinto altrettanto inquietante per poi passare a inquadrature in tele-obiettivo di gente che si scambia soldi. E’ proprio il passaggio dei soldi di mano in mano che costituisce il filo conduttore di questa sequenza. Vediamo ancora una donna, stavolta su un divano. Dalle riprese si passa senza soluzione di continuità alle foto di sospettati che trafficano in banconote, con sopra appunti che indicano date, luoghi e supposizioni su chi siano le persone fotografate e cosa stiano facendo. Insomma il classico frutto di mesi di indagini e appostamenti condensato in foto scribacchiate di appunti. Col senno di poi, risulterà chiaro che si tratta di materiale accumulato da Jimmy Hart (collega di Chance) sulla pista che lo condurrà al falsario Masters e alla morte. Queste foto però divengono esse stesse opere d’arte, paragonabili ai dipinti intravisti nel corso di questo serrato montaggio. La macchina da presa ne esplora i volti e le scritte come fossero paesaggi, facendoli così diventare un tutt’uno con le inquadrature dei volti su tela e con gli shoot delle due donne (che ritroveremo come personaggi del film). Il flusso di immagini prosegue sotto l’incessante brano dei Wang Chung che scandisce il ritmo visivo di questa sequenza di puro montaggio. Quando raggiungiamo l’apice parossistico di questa incredibile ordalia audio-visiva, d’improvviso tutto si interrompe col rumore di una tela che viene stesa per terra da Rick Masters. La sensazione che lasciano questi due minuti e mezzo è estatica perché abbiamo appena assistito ad un pezzo di cinema non-narrativo che racconta molto più di intere scene di dialogo, prendendoci sia per la pancia, con l’alchimia irresistibile di immagini e musica, sia per la testa, facendoci immaginare storie che colleghino il flusso che abbiamo appena visto. Ci piace credere che se il maestro del montaggio delle attrazioni, Sergej Ėjzenštejn (noto per la Corazzata Potemkin, grande sperimentatore e anticipatore delle forme cinematografiche nonché teorico sopraffino), fosse stato ancora vivo negli anni ’80, avrebbe certamente gradito questa sequenza dei titoli di testa in cui il significato complessivo corrisponde a più della mera somma delle parti che la compongono.
Una jam-session visivo-musicale sulla città degli angeli

Bastava anche solo questo strabiliante attacco per entrare nella storia del cinema ma invece Friedkin ci riesce dopo un intero film. Che sarà assolutamente all’altezza di questo incipit anticonvenzionale perché la stessa trama di Vivere e morire a Los Angeles, così come la sequenza dei titoli di testa, proseguirà per scarti improvvisi, pause tirate al limite, spiazzamenti e virate imprevedibili, esattamente come in una improvvisazione musicale. Il film segue appunto l’andamento di una sorta di jam-session visivo-musicale, pur non perdendo mai di vista la narrazione principale. In questo giocano un ruolo fondamentale le musiche del gruppo inglese new wave, Wang Chung (chiamati così per l’assonanza del nome con il suono delle chitarre elettriche), scelti da Friedkin per il loro pop-rock raffinato e al tempo stesso energico, capace di raccontare al meglio le albe e i tramonti di una Los Angeles molto lontana dai panorami patinati visti in altri film. Le location scelte dal cineasta, con i capannoni abbandonati, i quartieri delle gang, i locali di spogliarello, la prigione, raccontano infatti una città moralmente allo sbando, fotografata elegantemente dallo stesso Robby Muller di Paris Texas (1984). Fin dai sobborghi newyorchesi de Il braccio violento della legge (The French Connection, 1970) William Friedkin ha sempre prestato particolare attenzione nella scelta di location non banali, che rendano la visione che c’è alla base del suo cinema, iperbolico ma calato perfettamente nel reale.
I Wang Chung furono chiamati dal regista a comporre la colonna sonora prima delle riprese, ma bensì sulla base della sceneggiatura definitiva, come faceva anche Sergio Leone con Ennio Morricone all’epoca. In questo modo il montaggio fu realizzato sulle musiche già composte appositamente e il risultato è che si sposano alla perfezione con le immagini di questa città in decadenza che conserva però ancora guizzi di straordinaria bellezza. Gli improvvisi riff di chitarra elettrica, piano e suoni elettronici di brani come quello dei titoli di testa o di Black-Blue-White e Wake-up stop dreaming si alternano a ballate dalle cadenze blues come Lullaby, e a brani pop dall’andamento sostenuto e dai suoni molto ricercati come la stessa To live and die in La e Wait, che aprono e chiudono la pellicola, in cui i sintetizzatori, in perfetto connubio con strumenti rock, creano tappeti sonori dalla suggestione unica.
Un cattivo dalla vena artistica

Come abbiamo visto, la sequenza dei titoli di testa anticipa molte cose a cui assisteremo nel corso del film, in particolare la presenza insistita dei quadri rimanda alla vena pittorica del villain, cioè il crudele Rick Masters, interpretato da Willem Dafoe, in uno dei suoi primi ruoli luciferini dopo che l’anno precedente era stato scoperto da Walter Hill con Strade di Fuoco. Masters non uccide mai per sadismo ma solo per pura utilità. Stupisce però come un uomo così incline alla violenza possa avere un talento artistico così profondo e questo infatti dona una notevole tridimensionalità al personaggio, che sfugge ai ritratti monocordi e stereotipati di molti cattivi dei polizieschi. Rick è apparentemente impassibile quando tratta i suoi loschi affari ma è chiaro che è consumato dal sacro fuoco dell’arte quando si trova davanti ai suoi dipinti e arriva anche a bruciarli, forse per una insoddisfazione atavica nei confronti della vita stessa.
Segnaliamo tra le fila dei cattivi anche un giovane John Turturro, perfetto nei panni di Carl Cody, laido galoppino di Masters.
Un protagonista carismatico quanto antipatico

Le vere scintille del film toccano però a Chance, il detective pronto a tutto pur di fermare il bandito che ha ucciso il suo amico. Giovane, dinamico e spericolato, il suo hobby principale è il bungee jumping dai ponti di Los Angeles, giusto per farci capire quanto l’adrenalina sia un ingrediente fondamentale della sua vita. Della caccia a Masters ne farà una vera e propria ossessione, arrivando a compiere dei veri e propri atti criminali pur di arrivare all’obiettivo. I confini tra tutore della legge e delinquente si faranno dunque molto labili e questo metterà in discussione anche il rapporto con il nuovo gemello, Vucovich, per non parlare di altre conseguenze che non diremo qui.
Chance non esita a ricattare e trattare aspramente Ruth, l’informatrice con cui ha una relazione. Si capisce che la donna è per lui soltanto un mezzo per arrivare a un fine. Non ci stupiremmo se il personaggio principale sia risultato addirittura sgradevole a qualche spettatore, a causa della superbia, dei modi spicci con cui tratta le persone che gli stanno vicino e dell’incoscienza con cui mette in pericolo sé stesso e gli altri pur di perseguire i suoi scopi. Come se non bastasse Chance non pronuncia neanche battute cool, come sono soliti fare gli eroi dei polizieschi d’azione, da Clint Eastwood a Bruce Willis. È invece sbruffone e fin troppo sicuro di sé, nonostante arrivi a sbagliare clamorosamente in certi frangenti. Eppure il carisma che possiede buca lo schermo, è palpabile, grazie alla fisicità e all’intensità dell’interpretazione di William Petersen. E’ dunque proprio nel protagonista uno degli elementi di rottura di questo cult.
L’inseguimento
L’inseguimento è la forma più pura di cinema, qualcosa che non può essere fatto con altri mezzi espressivi, che siano la letteratura, il teatro o la pittura. Al cinema l’inseguimento deve sembrare spontaneo e fuori controllo, ma deve essere meticolosamente coreografato, non fosse che per ragioni di sicurezza. Il pubblico non dovrebbe mai essere in grado di prevedere gli sviluppi. Fa gioco avere passanti innocenti che rischiano di essere feriti o uccisi. Quando vedo macchine che sfrecciano in strade deserte o in mezzo al nulla, non avverto un senso di pericolo. I veri inseguimenti mozzafiato avvengono in mezzo al traffico cittadino o su autostrade affollate.
Questi sono alcuni dei dettami sull’inseguimento come forma d’arte precipuamente cinematografica, che Friedkin propone nella sua bellissima autobiografia Il buio e la luce. Infatti vengono applicati alla lettera in una delle scene madri di To live and die in LA e cioè in quel forsennato inseguimento sulle strade prima, in autostrada poi, che gareggia per intensità, dinamismo ed efficacia visiva con quello storico de Il braccio violento della legge.
Macchina da presa piazzata in punti impossibili, camera-car che seguono l’auto di Chance in parallelo per poi salire improvvisamente con un dolly verso le corsie superiori in cui sfrecciano le macchine degli inseguitori, soggettive mozzafiato e teleobiettivi volutamente instabili che danno il senso della precarietà fisica. Il tutto reso però con un montaggio preciso che non fa mai perdere allo spettatore il senso dell’azione e chi sta inseguendo chi. Il risultato sono 8 travolgenti minuti di adrenalina e precisione millimetrica nella messa in scena e nel montaggio. Se c’è qualcuno che ha reso le scene di inseguimento arte quello è certamente Friedkin.
Un film irripetibile con un finale spiazzante (Spoiler)
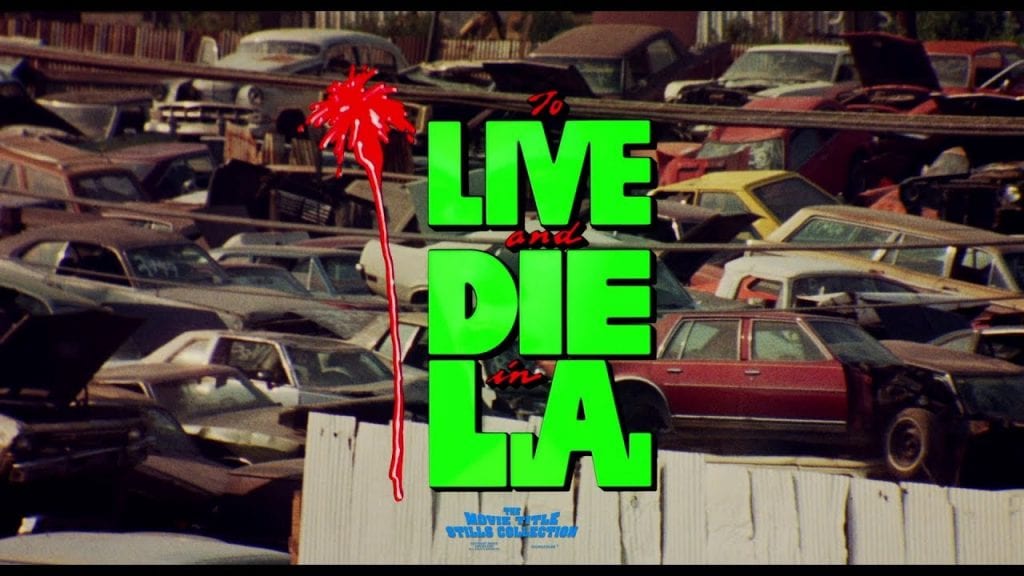
Ciò che rende Vivere e morire a Los Angeles ancora più unico è il finale totalmente spiazzante. Il nostro Chance viene fatto fuori in malo modo da uno scagnozzo di Masters, con una fucilata in pieno volto. Nel momento in cui l’obiettivo è vicinissimo, l’eccessiva spavalderia del protagonista viene dunque punita. Sarà il pavido collega Vucovich a concludere la missione dell’amico. Non solo ma egli sostituirà Chance anche nei rapporti con l’avvenente informatrice Ruth, arrivando perfino a vestire gli stessi panni e ad appropriarsi della camminata e dei modi del collega ucciso. Un nuovo Chance è dunque in città, speriamo un po’ più accorto e premuroso del precedente.
Come si diceva, la rottura dei canoni del genere operata da Friedkin con To live and die in LA costituisce un esempio abbastanza unico negli anni ‘80, insieme col già citato Manhunter. Non che siano mancati in seguito capolavori nello stesso genere che hanno certamente innovato sotto altri aspetti (Demme con Il silenzio degli innocenti, Singer con I soliti sospetti, Fincher con Seven e Zodiac), sarebbe assurdo affermare il contrario. Ma quella felice alchimia di immagini, musica, trama imprevedibile, personaggi per nulla scontati, al limite della sgradevolezza, con cui fu realizzato Vivere e morire a Los Angeles rimane davvero una rarità nel panorama del thriller poliziesco di quegli anni e oltre.
