Ogni 8 marzo con buona pace del paese reale ci si sbraccia in proclami facili e consolatori sulla disparità di genere, ovunque è un fiorire di mimose, appelli e slogan. Ma guai a parlare di femminismo: il rischio è quello di essere etichettate come “aggressive”, “arrabbiate”, addirittura “antiquate” e discriminatorie nei confronti degli uomini. Dire “io sono femminista” infastidisce, fa paura, non ha nulla di rassicurante, e rimette in campo i concetti di cambiamento e rivoluzione: cambiare le categorie del pensiero e ribellarsi ad una visione maschile del mondo inclusiva e dominante, destabilizza. La società in cui viviamo continua a svilupparsi nel nome di vecchi modelli patriarcali interiorizzati dallo stesso universo femminile, e il quotidiano è spesso uno spazio fatto e pensato su misura per gli uomini, a partire dal linguaggio; per molti invece il femminismo sarebbe finito con le conquiste delle nostre madri e potrebbe addirittura suonare come un termine obsoleto. La strada al contrario è ancora lunga ed è per questo che oggi tutti (uomini e donne) abbiamo ancora bisogno di parlare di femminismo.
1. Il linguaggio
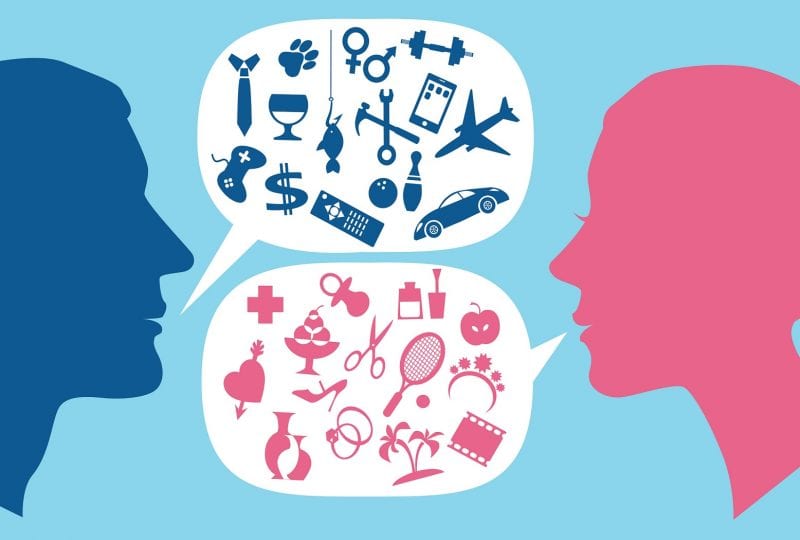
Per un breve periodo di tempo ci si era persino illusi che la disparità di genere fosse ormai superata: era bastato che cadessero alcuni veti in ambiti tradizionalmente destinati agli uomini o che le donne cominciassero a rivendicare il proprio diritto a essere lavoratrici oltre che madri e mogli. Niente affatto: il recente movimento del #metoo, i dati in aumento sui casi di femminicidio, la disparità salariale, hanno riacceso i riflettori sulla questione femminile. Si è fatta strada una nuova consapevolezza dell’essere donna: un’intera generazione che poteva comodamente starsene seduta sul diritto al voto o all’aborto, conquistato da chi prima aveva lottato per l’uguaglianza e la libertà, si è ritrovata a dover portare la battaglia al livello successivo, quello meno evidente e visibile, quello che si annida ad esempio tra le pieghe del linguaggio. Quante volte abbiamo sentito dire “Ministra suona male!”? No, non suona male, esiste, solo non si è abituati a usare il corrispettivo femminile di un termine generalmente declinato al maschile, perché riferito a una professione per anni prerogativa degli uomini. La lingua riflette i cambiamenti sociali ed ecco che ministra inizia a vivere nel momento in cui sempre più donne cominciano ad assumere ruoli a cui prima non avrebbero avuto accesso. E allora viva le avvocate, le architette, le poliziotte, le sindache, le ministre!
2. La violenza sulle donne

Sono passati solo 25 anni da quando la legge sullo stupro riconobbe la violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la morale pubblica; eppure in questi casi sono ancora molte le attenuanti spesso accordate all’assassino. La maggior parte dei delitti si consuma in ambito familiare, perpetrato da uomini che non riconoscono alla donna il diritto di vivere diversamente dalle proprie idee di femminilità. Il lockdown non ha certo aiutato: secondo alcuni dati Istat durante i primi sei mesi del 2020 i femminicidi sono stati quasi la metà del numero di omicidi, contro il 35% dell’anno precedente.
Denunciare non è facile, soprattutto se si considera il pensiero ancora diffuso nell’opinione pubblica che tende a giustificare la violenza sulle donne con frasi del tipo: “Se si veste così…”, oppure “Se cammina da sola a quell’ora della sera…”. Affermazioni che spostano la colpa dal carnefice alla vittima.
3. Lavoro: una donna dovrà sempre faticare il doppio

Basta guardare l’ultima formazione di governo del nostro paese: su 23 ministri, solo 8 sono donne. Nonostante i passi in avanti, le posizioni di potere continuano a essere ricoperte da uomini, mentre i pregiudizi di genere quando si ha a che fare con mansioni tradizionalmente maschili si sprecano con battute come: “È un lavoro pericoloso! Come fai? Non hai abbastanza forza!”. E a chi non è capitato di essere chiamata “Signora, signorina” invece che con il titolo che le competerebbe?
La pandemia poi ha fatto il resto, se si calcola che sono soprattutto le donne ad aver pagato il prezzo più caro delle chiusure dell’ultimo anno: licenziate o costrette a conciliare con straordinarie doti acrobatiche figli e carriera. Sempre l’Istat ci dice che il 98% dei posti di lavoro persi in questo anno, era occupato da donne, molte delle quali impiegate nel commercio, nei servizi sociali o nel settore domestico (collaboratrici domestiche, baby sitter, badanti).
4. Maternità: essere o non essere madri

Difficile vivere la propria femminilità fuori dagli schemi perpetrati per millenni: una donna deve accogliere, accudire, essere gentile e materna, altrimenti “spaventi gli uomini”. E guai ad arrivare alla soglia dei 40 anni senza figli, peggio ancora se quella di non averne è una scelta: “Vedrai, prima o poi arriverà. La maternità è un istinto naturale”. La malcapitata di turno avrà sempre qualcosa che non va, un che di irrisolto, dovrà giustificarsi, spiegare o peggio ancora vergognarsene. Chiediamoci invece se non sia piuttosto un imperativo sociale, lo stesso per cui le madri non avrebbero diritto a urlare le proprie paure, ma solo a decantare le gioie della maternità.
5. Educare alle differenze

Il femminismo educa al rispetto delle differenze e al superamento della mascolinità tossica. Coinvolgere gli uomini è il primo passo perché nasca una generazione di bambini e bambine libere da certe aspettative sociali. La via è tracciata, basta continuare a seguirla, assecondando il proprio essere donna e senza il timore di poter affermare: “Io sono femminista”. Caparbie e irriducibili.
